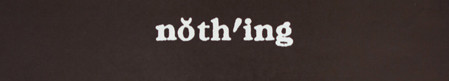Pubblicato in Massimo Puliani-Alessandro Forlani, Play Beckett. Visioni multimediali nell'opera di Samuel Beckett, Halley, Matelica 2006.
L’iniziazione di Beckett alla grammatica radiofonica, filmica, video-televisiva avviene … per caso (per caso? Con Beckett la parola assume un valore filosofico). Come all’origine del suo percorso drammaturgico avvolto da un’enigmatica illuminazione. Già dalla stesura di Aspettando Godot Beckett annuncia il limite della sua prosa e la necessità di superarla con la drammaturgia: “Ho cominciato a scrivere Godot per distendermi, per sfuggire all’orribile prosa che scrivevo a quel tempo. Non ho scelto di scrivere una pièce. Si è trovata così.” .
Ora, se volessimo trovare la parola giusta per indicare quest’iniziazione di Beckett alla grammatica radiofonica, filmica, video-televisiva potremmo considerare questo percorso come una … folgorazione. Certa inquietudine e curiosità intellettuale – la stessa che in gioventù lo interessò per esempio al severo studio di Dante, Vico, Joyce ma, anche, alle comiche di Charlie Chaplin e Buster Keaton, Stanlio e Ollio, dei Fratelli Marx – spinge Beckett, quand’anche in principio diffidente o poco interessato alla radio, al cinema e la televisione se non da spettatore fruitore, ad accettare per “provare a produrre qualcosa, oppure no: non ho mai pensato prima alla tecnica del dramma radiofonico” , la commissione “senza condizioni” della BBC per Tutti quelli che cadono (1956); la richiesta di una sceneggiatura cinematografica che diverrà Film della Grove Press di New York (1963); la proposta di videodramma (tele-play o video-teatro), ancora da parte della BBC, di Dì Joe (1965).
Se questo può apparire in contraddizione con la spavalda affermazione di Beckett del rifiuto di lavorare su commissione, o di “insegnare ad altri ciò che io stesso non so”, è d’altra parte interessante e fattiva conferma di un’intelligenza poetica pronta a superarsi ed a mettersi in discussione.
Folgorazione che, dopo la storica “prima” di Aspettando Godot nel 1953 al Théatre de Babylon e dopo il corpus drammaturgico composto dai più noti, rappresentati, re-interpretati e discussi capolavori del Teatro del Novecento (da Finale di partita a Giorni felici a L’ultimo nastro di Krapp, eccetera) giunge nel 1965 con Film a un punto di non ritorno. Oppure, per dirla con Franco Quadri, “all’inevitabile termine” della pièce multimediale.
Con i Dramaticules l’opera di Beckett approda ad un’idea dell’arte che attraversa e si nutre dei linguaggi più svariati, fino a costituirsi “genere a sé”. I Dramaticules sono sceneggiature in-finite, découpage o story-boards, pensieri letterari e microromanzi; materiali poetici per progetti sonori, visivi, materiali/immateriali come i sogni e gli incubi.
Perché questo sperimentare di Beckett coi linguaggi multimediali? Perché, nella ricerca che gli è propria di perfezione, egli “dismette” a un tratto il linguaggio teatrale (nel momento, si potrebbe affermare, in cui coi Dramaticules ne comprende e addirittura supera, per sempre, lo statuto) e si arrischia ad apprenderne di più (della radio, del cinema, del video: che sono fra loro ben differenti), e nuovi? Ove il rischio avrebbe potuto essere l’incapacità di comprenderli (o comprenderli solo in parte, e male) e di padroneggiarli; con conseguente banalizzazione, appiattimento o perdita di incisività di contenuti e principi. Forse, è la risposta, per lo stesso motivo per cui egli, di lingua e cultura anglosassone, decide di abbandonare la prosa in inglese e di scrivere un dramma in francese. Ovvero per un avvertimento di insufficienza al proprio sentire strutturale e linguistico; l’anelito a un superiore grado di esattezza, definizione, necessità.
Se la parola è ormai superflua, svuotata, “menzogna” (secondo una conversazione di Beckett con il cameraman Jim Lewis) e tale è il tessuto, il ritmo, il luogo privilegiato, la forma e il modo di trasmissione della parola, la via che Beckett percorre è quella dell’immediatezza dello sguardo, dell’immagine rivelata o dato visivo, del suono in sé non mediato né altrimenti tradotto.
Beckett notò, assistendo in televisione a riprese delle proprie opere teatrali, che lo strumento televisivo non era semplicemente un tramite, bensì un nuovo mezzo espressivo, che poteva raggiungere livelli diversi rispetto a letteratura e teatro e generare suoi propri significati. Si trattava di uno spazio “altro”, specifico; differente dalla pagina e dal palcoscenico per il quale elaborare appropriati testi da redigere in una lingua appropriata. Pièces, opera artistica tuttavia, non adattamento teatrale televisivo, non fiction. Uno strumento che offriva soprattutto il totale controllo della forma drammatica: non solo la possibilità di definire, con assoluta precisione, i movimenti della telecamera e degli interpreti (consapevolezza già evidente in Eh Joe); l’intensità e la durata di un suono, di un’immagine (ovvero il potersi esprimere in un linguaggio ritmico, numerico, quasi sensoriale); ma che anche determinava i modi dello sguardo. Proprio dello sguardo e allo sguardo certo, per esempio, attraverso la telecamera, era ormai l’avvertire di quel senso di tragico, di disperata ineluttabilità della fine e di impotenza delle grigie ombre dai lunghi capelli: che troppo, nell’evocare “vecchi sfatti” lasciati all’immaginazione, all’interpretazione di registi e costumisti, aveva forse già detto (scritto) senza mai comunicarlo abbastanza.
Beckett intuì la spietatezza della telecamera: che – per ferocia, brutalità, voracità ferina che proprie le sono (abitudine oggi del linguaggio mediale) – appropriatamente definì “Occhio Selvaggio”. Così come intuì il senso del replay all’apice che è Quad della produzione televisiva. Realizzato per la Scuola di Danza di Stoccarda nell’81, a pochi anni dalla fine, il videodramma è in un certo senso un testamento multimediale, una profezia di Beckett sul destino del nostro rapporto con i molti media(come, ancora nel 1958, predizione è il magnetofono personale di Krapp acceso “una tarda sera, nel futuro”), e un’entropia. Il tempo non è più ritorno eterno, forse Salvezza, come in Godot; il ripetere non è più parodia, destrutturazione – come in Commedia – in funzione di nuove, diverse possibilità; bensì replica, modulare e algoritmica. E seriale diviene ciò che si ripete; riproduzione, consumo. Il gioco (appunto play) è reiterato e ripreso all’indietro (play-back), da capo (re-play); ma non ha né protagonisti né soluzione. Quad può solo avere spettatori e, in definitiva, neppure questi sono necessari. Si chiede a chi gioca, e a chi guarda, di conformarsi e di rispondere ad uno schema, di entrarvi, accettarne le regole e assecondarne il ritmo. E inesorabilmente di divenire, infine, parte integrante di quello schema. La poetica, romantica condanna a “trovare il modo di passare il tempo, darsi l’impressione di esistere” di Vladimiro ed Estragone, nel passaggio attraverso le nuove tecnologie è svuotata di ogni lirica consapevolezza: diviene piuttosto un avvertire contemporaneo, reale, di una condizione che sa di meccanica e robotica ma pur sempre di natura antropologica.
Interessante è l’analisi – e questo è in parte l’intento del presente volume – dell’evoluzione di questaalfabetizzazione multimediale, da parte di Beckett e dei suoi più immediati e costanti interlocutori (quali per esempio Alan Schneider), nel trentennio dal ’57 (l’esordio in radio con Tutti quelli che cadono) alla morte; che lo sorprende – pare – a metà di un progetto di remake di Film il cui protagonista avrebbe dovuto essere Vittorio Gassman.
Si pretende nella ricerca linguistica beckettiana “una coerenza e padronanza rigorosa, sempre ed immediatamente tesa a cogliere l’essenza del mezzo che usa, a basare l’espressione soprattutto, se non esclusivamente, su ciò che lo definisce e lo caratterizza; una scrittura che privilegia il suono nelle pièces radiofoniche e l’immagine in quelle per la televisione” . Ma questo è vero in parte; nei lavori più maturi: mentre – come per esempio si può ancora scoprire nel testo scritto di Tutti quelli che cadono, o nello script di Film – a principio di ogni tentativo con l’inusuale, altro medium rispetto al teatro, alla prosa, incertezze impedimenti e ripensamenti (di natura tecnica, soprattutto) se ne trovano. Che però non sminuiscono o mettono in dubbio il valore dell’opera; anzi – come le gag dei tre cappelli o i “passaggi di palla” di Vladimiro ed Estragone – dichiarano le intenzioni di Beckett circa lo specifico linguaggio adottato. Definiscono di passaggio in passaggio cosa è superfluo e cosa no; cosa è necessario.
Il numero e il movimento delle camere, la diffidenza nei confronti dell’effetto speciale, l’intensità (il buio) delle luci, la combinatoria delle entrate ed uscite di macchina, i passi, le percussioni: ognuno di questi elementi è portatore di significati e contenuti; ognuno, nella produzione multimediale di Beckett, ha assunto eloquenza “geroglifica” o, se vogliamo, geometrico-ontologica.
Copertina: Joseph Kosuth