Anticipazione del mio saggio su Les aiguilles et l’opium di Lepage per il volume antologico di Vincenzo Del Gaudio e Alfonso Amendola sul teatro tecnologico. (prima parte)
Revival o ripensamento?
Nel 2012 Bob Wilson riproponeva sulle scene, in una nuova versione molto fedele all’originale, il capolavoro senza tempo Einstein on the beach (1976); Marina Abramovich presentava una sorta di “teaser” teatrale delle sue storiche performance con The Biography Remix a Romaeuropa, mentre nel 2016 Wim Vandekeybus rilanciava In Spite of Wishing and Wanting, suo storico spettacolo di danza del 1999 con un nuovo cast di dieci giovani danzatori chiamati a interpretare i temi del desiderio, del sogno e della passione.
Robert Lepage (Quebéc city, 1957) nel corso della sua trentennale carriera di attore e regista, ha riproposto, insieme con la sua compagnia Ex machina[1], a distanza di vent’anni dalle prime edizioni, ben due suoi lavori teatrali. Ci prova dapprima nel 2003 con la riedizione per il Festival des Amériques in Québec, del suo primo spettacolo come regista: il kolossal di sei ore Trilogie des Dragons (1987)[2], rilavorandoci successivamente nel 2008 per dare vita a The Blue Dragon[3], un vero e proprio “sequel” che lo vede impegnato anche come attore.
Il 2013 è invece, l’anno del rilancio di uno dei suoi spettacoli-culto, che lo ha reso famoso al grande pubblico internazionale, Les aiguilles et l’opium[4]; precisamente, dopo il debutto nel 1991 che lo vedeva unico interprete in scena (a Palais Montcalm, Quebéc city; nel 1992 trionferà al Festival d’Automne di Parigi dove otterrà il Gran Premio della Critica come miglior spettacolo straniero), si ebbe una prima ripresa nel 1994 con l’attore canadese Marc Labrèche in versione francese e inglese (Needles and Opium), poi una seconda nel 1997, con l’interpretazione dell’italo-argentino Nestor Sayed dalla traduzione italiana di Franco Quadri [5].
Robert Lepage nel 2015 decide di riprendere questo pluripremiato “solo show”, definito una sorta di “teatro musicale da camera”, con una rinnovata tecnologia in scena e con più attori per esaltare maggiormente la scrittura scenica. Così una delle sue prove attoriali più riuscite, con un testo originale e profondo, basato sulle vite di Jean Cocteau e Miles Davis e sulle reciproche dipendenze da droghe, torna a rivivere sul palcoscenico in una forma tecnologica molto innovativa e al tempo stesso, rispettosa dell’originale.
La biografia di Cocteau, i suoi film, i suoi libri (soprattutto Lettres aux Américains e Opium), l’amicizia con i grandi pittori surrealisti e con Picasso (documentata anche nel film Le testament d’Orphée, 1960), con musicisti e danzatori come Satie e Nijinskij, la partecipazione ai grandi movimenti artistici del primo Novecento e dall’altro lato la biografia di Davis, i fermenti del cool jazz negli anni Cinquanta a New York, diventano l’occasione per parlare di arte, ispirazione e droga. Ne Gli aghi e l’oppio l’attore è appeso a una fune e si muove acrobaticamente in un dispositivo scenico dinamico (con soluzioni sceniche differenti nelle due versioni del 1991 e 2013, ma con eguale, potente effetto visivo).
Sarà proprio questo spettacolo a consacrare Lepage come il grande protagonista del nuovo “teatro immagine” ma con un senso profondamente diverso dalla originaria definizione coniata, come è noto, da Bonnie Marranca[6] per Bob Wilson.

Il suo è un “image-based work” in cui il dispositivo scenografico dove vengono proiettate le immagini è progettato per essere tutt’uno con l’artista-acrobata che appare, così, come immerso nel vortice delle immagini in movimento, avvolto dalle atmosfere sempre diverse che accompagnano il “viaggio” del personaggio, costantemente alla faticosa ricerca di un equilibrio interiore e di una pacificazione con i propri demoni interiori o con il passato. Il dispositivo è lo spazio sempre mutevole, della rappresentazione: le immagini proiettate, manipolate in diretta, interagiscono con il corpo dell’attore che vola sopra una macchina-involucro che contiene i dubbi esistenziali di ognuno di noi.
Uno spettacolo del dolore, senza un’ombra di morale.
Les aiguilles et l’opium è la storia di un franco-canadese, Robert, che si trova a Parigi per un lavoro di doppiaggio cinematografico di un documentario sulla presenza d Miles Davis a Parigi, al Festival del Jazz nel 1949; in preda a sofferenze sentimentali e a crisi di solitudine, nella sua camera d’albergo, Robert rivive il proprio intimo dramma di isolamento e dipendenza d’amore proprio nelle figure di due grandi esistenze al bivio: Miles Davis e Jean Cocteau, entrambi dipendenti da droghe (eroina e oppio)[7]. Sia Cocteau che Davis riuscirono a disintossicarsi, il primo inizialmente con l’ipnosi, poi rinchiudendosi per sei settimane in una clinica dove scrisse e illustrò il volume Opium “per lasciare una traccia di questo viaggio che la memoria dimentica”, il secondo con il metodo drastico, noto col nome di cold turkey [8].
Alcuni critici musicali come Arrigo Polillo sostengono che furono proprio le migliorate condizioni di salute la spiegazione dell’improvvisa maturazione della musica di Davis, che lo impose come uno dei protagonisti della scena jazz al Festival di Newport (1955). All’oppio e al dolore per la disintossicazione è dedicata l’opera autobiografica di Jean Cocteau Opium, scritta cinque anni dopo la morte dell’amico Raymond Radiguet: durante questi mesi l’artista surrealista scrive e disegna in un unico atto creativo:
Non aspettatevi che io tradisca. Naturalmente l’oppio rimane unico nel suo genere e l’euforia che procura superiore a quello della salute. Devo all’oppio le mie ore più perfette.Peccato che invece di perfezionare la disintossicazione, la medicina non tenti di rendere l’oppio inoffensivo. Ma qui ricadiamo nel problema del progresso. La sofferenza è una regola o un lirismo?[9]
Uno spettacolo, dunque, sul dolore che accompagna la fine dell’estasi e dell’euforia dovuta alle droghe, ma che può essere anche una nuova fonte di ispirazione:
Il discorso della dipendenza e della disintossicazione è centrale. Sia Davis che Cocteau cercano di uscire dal dolore della loro dipendenza amorosa e lo fanno usando un balsamo, la droga, che crea un’altra dipendenza. E’ un movimento circolare. Entrambi, però, con la droga arrivano a punti della loro produzione artistica, splendidi. Ed entrambi, smettendo, riescono ugualmente a cambiare musica e scrittura facendolo ancora meglio[10].
Coincidenze geografiche uniscono gli artisti nominati: nel 1949 quando Cocteau rientrava in Francia in aereo dall’America (dove era andato a presentare il lungometraggio, L’Aigle à deux têtes, scrivendo la famosa Lettres aux Américains), Miles Davis ritornava negli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle Parigi[11], la vita artistica di Saint-Germain-des-Pres e Juliette Gréco, con la quale aveva avuto una breve ma intensa storia d’amore nella stessa camera d’albergo, l’Hôtel La Louisiane in cui si ritrova il protagonista, Robert, che invece ha lasciato il Québec per Parigi, dopo una rottura con il compagno che si trovava a New York.
Un senso di angoscia esistenziale, di impossibilità di fuga, di solitudine pervade lo spettacolo. Fanno da contrappunto al racconto teatrale, materiali d’archivio tra cui i concerti di Miles Davis, le sue colonne sonore, le immagini in bianco e nero della New York degli anni Cinquanta, la musica di Satie e le suggestioni dai disegni di Cocteau e dal suo cinema. Lo spettacolo è anche un modo originale per parlare delle avanguardie, dell’esistenzialismo, del rapporto tra la cultura americana e quella europea.
Immagini molto realistiche di una camera d’hotel che raccoglie le ossessioni dei protagonisti (Cocteau andò a vivere in hotel dopo il ricovero alla clinica Saint-Cloud e Davis si rinchiuse in una stanza per 21 giorni per disintossicarsi dalla droga) e dialoghi di una disarmante quotidianità, si alternano a momenti decisamente visionari: lo spettacolo vira continuamente dalla realtà ad una sua riproduzione sghemba, distorta, maniacale, quella avvertita proprio, attraverso l’abuso di droghe.
Annota Lepage:
Le droghe forniscono uno strumento di trasformazione sia scenico che narrativo (…) Il dolore della disintossicazione ha portato gli artisti a un genuino ritorno all’ispirazione. La trasformazione non avviene solo perché i narcotici ti fanno vedere scarafaggi o alterano il tuo stato d’animo, ma perché ti trasformano a un altro livello.[12]
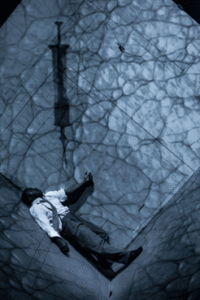
Uno spettacolo, molto personale, quasi intimo, su cui Lepage dice:
E’ il più soggettivo, il più autocoinvolgente dei miei lavori. Malgrado mi interessino soltanto le nuove drammaturgie e le nuove risorse tecniche, qui mi lascio andare a un approccio intimo-poetico alle forme del dolore, anche convinto come sono che il teatro del XXI secolo debba affrontare questi percorsi, più che basarsi su grandi commedie e tragedie (…) L’estasi per problemi di cuore spinge quasi a un piacere del dolore, e col tempo mutano solo i rimedi estremi, che per l’etereo Cocteau erano gli abusi d’oppio, e per Miles Davis uomo nero di Harlem, era l’eroina. Sì, non è sbagliato definirlo uno spettacolo del dolore, senza un’ ombra di morale[13].
Come non essere d’accordo con Dominique Hasselman che in una recensione on line allo spettacolo di Lepage su un blog francese, scrive: “A ciascuno la sua spirale, a ciascuno la sua dose, a ciascuno la sua sostanza, a ciascuno i propri sogni, a ciascuno le proprie devianze: il mondo sarebbe triste se non esistesse la possibilità di uscire dai limiti[14].
Non più “one-man-show”: “A volte una folla esprime meglio la solitudine”
Lepage nel 2013 riprende lo spettacolo aggiungendo altri attori (oltre a Marc Lebréche, Wellesley Robertson, danzatore e acrobata con una figurante per Juliette Gréco) e modificando il dispositivo scenografico, arricchito della più attuale tecnologia digitale, il videomapping su superficie in movimento, per farne una versione “più matura”; queste le motivazioni:
Ero terrorizzato dall’idea di confrontarmi con i fantasmi dei miei vecchi ideali; cerco sempre di evitare il più possibile di rivisitare i miei primi spettacoli. E poiché non c’è in me neanche un briciolo di nostalgia, ammetto che ho esitato a lungo quando Marc Labrèche mi suggerì di riprendere in mano Gli aghi e l’oppio per metterlo ancora in scena. Creato nel 1991, dopo una dolorosa rottura sentimentale, Gli aghi e oppio voleva essere una riflessione sugli impulsi e sulle circostanze a volte dolorose che portano alcuni artisti a creare, provando a fare un parallelismo tra la dipendenza d’amore e quella dagli oppiacei. Così mi sono imposto un duro lavoro di revisione delle vecchie registrazioni VHS d’archivio e ho scoperto che, anche se la scrittura scenica era indubbiamente vecchia, il soggetto non sembrava aver perso la sua rilevanza. Scritto molto prima di Internet, dei social media e dei fatti dell’11 settembre, le domande esistenziali del protagonista sono più universali che mai e la Lettera agli americani di Jean Cocteau sembra quasi profetica. Ma non era sufficiente rimontare lo spettacolo. Sentivo che era necessario approfondire, e completare la scrittura. Perché quando si tratta di sentimenti e di un amore conflittuale, ci sono cose che si comprendono solo molto più tardi
Il movimento del dispositivo di scena è la chiave di lettura della nuova versione e va interpretato come un aggiornamento della macchina assai modesta tecnologicamente parlando, quasi arcaica, della prima versione: in questo nuovo macchinario praticabile a forma di cubo con due lati aperti e rotanti, gli attori si muovono come acrobati ed entrano e escono da aperture laterali, restando in bilico legati a una fune, recitando sottoinsù mentre il dispositivo ruota; le proiezioni in videomapping seguono tale movimento ricreando di volta in volta, l’ambientazione richiesta (la camera d’hotel, la sala di doppiaggio, il concert-hall)
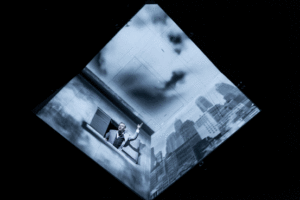
La tecnologia precede: inventa, dispone, prepara, ma a guidarla è la mano dell’uomo. Gli oggetti vengono fatti entrare in scena attraverso botole, da tecnici posizionati dietro il cubo e pronti ad allestire e disallestire il dispositivo. Anche in Jeux de cartes i tecnici, collocati su sedie con ruote sotto la scenografia circolare, permettevano la rapida fuoriuscita di elementi scenici, attraverso varchi invisibili, gli stessi da dove entravano e uscivano gli attori.
Questa modalità adottata anche da Les aiguilles et l’opium, crea una vera dissolvenza incrociata, in cui ogni episodio lascia il posto a quello successivo, distante spazialmente e temporalmente, senza soluzione di continuità dando l’impressione di voler giocare non più solo sulla frontalità teatrale, ma sulle mille variazioni delle inquadrature cinematografiche e confidando sulla capacità di raccordo dell’occhio dello spettatore.
Si perde, però, nell’aggiornamento del “software teatro” dell’ultima versione, la potenza delle immagini-ombra create live nel 1991; così Miles Davis offre il suo braccio a una siringa proiettata e gli oggetti disposti stavolta su un tavolino a vista degli spettatori, raccontano una storia di incontri parigini grazie a una webcam.
Perduta l’artigianalità, si acquista tecnicismo: la macchina-teatro diventa un luna park.
[1] “Abbiamo cominciato a definire il nostro lavoro attraverso tre elementi contenuti nel nome Ex machina. Prima di tutto è stata esclusa la parola teatro, dal momento che non è più la nostra esclusiva preoccupazione. Secondo punto, il nome Ex machina evoca macchineria. Ma per me macchineria non è solo l’imbragatura che fa volare Cocteau in Gli aghi e l’oppio. E’ anche nell’attore, nella sua abilità a recitare il testo, a essere parte di un ingranaggio del testo; ci sono meccanismi anche lì. Terzo punto, noi abbiamo rimosso la parole “deus” dalla frase che in origine annunciava un esito inatteso, sebbene io ritenga che abbiamo mantenuto una dimensione mitica e una senso di ricerca spirituale. Il meccanismo risultante e quello narrativo sono ancora imprevisti, misteriosi e spetta a noi scoprirli”. R. Lepage, Connecting flights, New York, Tcg, 1999, p.23.
[2] Così il giornalista Oliviero Ponte di Pino sintetizzava tra le pagine de “Il Manifesto” lo spettacolo-saga Trilogie des dragons firmato da Lepage con Théâtre Repère e da lui visto allo Spazio Ansaldo per MilanoOltre: “Una spianata coperta di sabbia, un misero gabbiotto di legno, un palo della luce, pochi oggetti scelti con cura, di immediata efficacia: questo è tutto quel che serve a Robert Lepage e ai suoi otto attori per raccontare, in sei ore, una vicenda che dura ottant’anni, dal 1910 ai giorni nostri, attraverso tre città (Québec City, Toronto, Vancouver)”, “Il Manifesto”, 3 maggio 1985. Su questo spettacolo e sulle produzioni di Lepage fino al 2005 vedi A.M.Monteverdi, Il teatro di Robert Lepage, Pisa, BFS, 2005. Ed inoltre L. Fouquet, Robert Lepage, l’horizon en images, Instant même, 2005
[3] The Blue Dragon è un focus su una delle numerose storie della Trilogia dei Dragoni. Pierre La Montaigne artista del Québec, decide di lasciare il proprio Paese per andare a vivere definitivamente in Cina aprendo una galleria d’arte a Shangai. Pierre lavora a una particolare forma d’arte cinese, la calligrafia. Lasciato a questo punto della sua vicenda, Lepage riapre nel 2008 il capitolo che riguarda Pierre e pone un’attenzione speciale alla sua vicenda personale vent’anni dopo gli eventi già narrati e che il pubblico, fedele alle “puntate” teatrali di Lepage, conosce bene. L’intervista a Lepage su The Blue Dragon è on line (insieme a molti altri saggi sul suo teatro) sul sito www.annamonteverdi.it
[4]Les aiguilles et l’opium: ideazione, scenografia e interprete: Robert Lepage; Musiche: Yves Laferrière, Yvan Ouellet Musica e interpretazione musicale sulla scena: Robert Caux; luci: Jean Hazel e Robert Beauregard: manipolazioni in diretta e regia di palco: Claude Lemay; direttore di scena: Robert Beauregard;creazione della scenografia: Les réalisations N.G.L. inc.
La versione del 2013 con testo e regia di Robert Lepage, ha come interpreti Marc Lebréche (poi Olivier Normand) et Wellesley Robertson III e una figurante femminile sempre diversa. La scenografia è di Carl Fillion. Musiche e concezione sonora: Jean-Sébastien Côté; immagini Lionel Arnould. Il Napoli Teatro Festival lo ha ospitato nel 2016.
[5]Nel triennio 1997/1999 Les aiguilles et l’opium avrà anche una versione spagnola (interpretata sempre da Nestor Sayed) e la tournée toccherà Spagna, Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perù, Brasile, Cile, Argentina, Uruguay.
Les aiguilles et l’opium è stato definito dalla critica “un lavoro supervisionario e magico” (“The New York Times”), “brillante, tecnicamente molto sofisticato, che miscela emozione e multimedialità” (“The Observer”), “geniale e sorprendente” (“The New Yorker”); la rassegna stampa italiana della tournée del 1997 (che ha toccato, tra gli altri, il Fabbricone di Prato, L’Arena del Sole di Bologna e il Vascello per RomaEuropa) incorona Lepage come “il Peter Brook del Québec”, “l’astro indiscusso del teatro di ricerca”, “il regista che si muove tra poesia e hight tech”, esaltando dello spettacolo, il riuscito l’impianto scenico multimediale con lo schermo mobile ed estensibile dove venivano proiettate immagini d’archivio con l’interprete sospeso in aria. Renato Palazzi la definisce una “raffinatissima pièce introspettiva” e ne elogia la “perfetta realizzazione di una compiuta ipotesi di espressione multimediale” (Mal d’amore multimediale, “Il sole 24 ore”). Per un errore di traduzione “Il Giornale d’Italia” intitola curiosamente la recensione “Le anguille e l’oppio di Lepage al Vascello”. La rassegna stampa internazionale è stata visionata personalmente presso gli archivi di Ex machina, Québec city.
[6] Dobbiamo a Bonnie Marranca la definizione di Theatre of the Images all’interno della cui categoria il critico americano fondatore del “Performance Arts Journal” ha raggruppato Breuer, Foreman e Wilson e per la seconda generazione, i Mabou Mines e il Wooster group di Elizabeth LeCompte. Il lavoro sull’immagine, il rapporto con le arte visuali e con la new dance diventa infatti, un segno distintivo del teatro sperimentale americano, da Robert Wilson a Richard Foreman a Meredith Monk. Fotografia e cinema costituiscono momenti determinanti, tra gli altri, dello Structuralist Workshop di Kirby (Photoanalysis, Double Gothic). In Italia il teatro-immagine ha visto tra i protagonisti negli anni Settanta, Memé Perlini, Giuliano Vasilicò e Mario Ricci. Cfr.: S.Sinisi, Neoavanguardia e postavanguardia in Italia, in R. Alonge, G.D.Bonino, Storia del teatro moderno e contemporaneo, Torino, Einaudi, 2001.
[7]Jean Cocteau scrive Opium nella clinica di Saint-Cloud nel 1929 proprio nei giorni di degenza per la disintossicazione. La creatività in forma di scrittura e di segno grafico diventano il modo per sopportare il dolore e per dargli forma artistica: “Scrivo queste righe dopo dodici giorni e dodici notti senza sonno. Lascio al disegno il compito di esprimere le torture che l’impotenza medica infligge a coloro che eliminano un rimedio che sta per diventare un desposta”.
[8]Sul periodo della disintossicazione, Davis racconta: “Stavo male e mi ero stancato di quella roba. Sapete ci si può stancare di tutto, ci si può anche stancare di aver paura. Mi sdraiai sul letto della mia camera e mi misi a guardare il soffitto per dodici giorni di fila durante i quali imprecai contro tutti quelli che non mi piacevano…Era come avere una grave forma di influenza, però un po’ peggio. Vomitavo tutto quello che cercavo di mandar giù. I miei pori si erano dilatati e puzzavo come se fossi immerso nel brodo di pollo. Poi finiì”. M.Crawford, Miles Davis: evil genious of jazz “Ebony”, gennaio 1961. Cit. da A. Polillo, Jazz. La vicenda e i protagonisti della musica afro-americana, Milano, Mondadori, 1975, pag.717.
[9] J. Cocteau, Oppio, 2001, Sel, Milano (tit. orig. Opium, 1930).
[10] C. Piccino, “Il Manifesto”, 15/10/1997 , Intervista a Lepage.
[11] Nel maggio 1949 Miles Davis attraversò per la prima volta l’Atlantico per partecipare col quintetto di Tadd Dameron al grande Festival del Jazz a Parigi. Non fece una gran figura, in verità: sull’enorme palcoscenico della Salle Pleyel, quel ragazzo dai capelli impomatati, che non sorrideva mai, che suonava in punta di piedi, dava proprio l’impressione di essere impaurito. Non era solo impaurito: era anche annoiato, scoraggiato. Lo confessò lui stesso dopo quando raccontò che proprio al ritorno dal suo viaggio d’oltreoceano cominciò a iniettarsi eroina nelle vene. A.Polillo, Jazz. La vicenda e i protagonisti della musica afro-americana, Milano, Mondadori, 1975, pag.716.
[12] R. Lepage, Connecting flights cit. pag.72.
[13] Intervista a Lepage di R. Di Giammarco, L’amore e l’oppio i turbamenti di Lepage, “la Repubblica”, 15 ottobre 1997.
D.Lafon, Des coulisses de l’histoire aux coulisses du théatre: la drammaturgie québecoise et la Crise d’Octobre, in “Theatre Research International”, n. 1, 1998.











